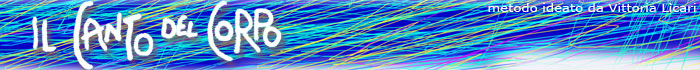- Home [Alt+h (Win), Ctrl+h (Mac)]
- menu di navigazione [Alt+n (Win), Ctrl+n (Mac)]
- contenuto [Alt+c (Win), Ctrl+c (Mac)]
- inizio pagina [Alt+t (Win), Ctrl+t (Mac)]
TEATRO ALLA SCALA. PAGLIACCI E CAVALLERIA RUSTICANA
7 febbraio 2011
TEATRO ALLA SCALA. PAGLIACCI – CAVALLERIA RUSTICANA
Pagliacci di Ruggero Leoncavallo e Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni costituiscono un binomio tradizionale nel repertorio operistico italiano. Il loro accostamento nella stessa serata appare coerente ed equilibrato: di durata più o meno simile, entrambe divise a metà da un intermezzo, le due opere affrontano tematiche “veriste”, l’una ispirandosi a un evento reale di cui l’autore era stato testimone, l’altra ricalcando l’omonima novella di Giovanni Verga. Entrambe ebbero un battesimo di alto livello: l’opera prima del ventiseienne Mascagni, con cui egli vinse nel 1890 il Concorso Sonzogno, ebbe la sua prima rappresentazione al Teatro Costanzi di Roma - oggi Teatro dell’Opera - il 17 maggio di quello stesso anno, con una coppia di “star” dell’epoca come Gemma Bellincioni e Roberto Stagno nei ruoli principali, mentre il titolo più celebre del già attivo Leoncavallo vide la luce il 21 maggio 1892 al Teatro Dal Verme di Milano, con Arturo Toscanini sul podio e, nella parte di Tonio, il celebre baritono Victor Maurel, che si confermava così creatore di immortali personaggi cinque anni dopo essere stato il primo Jago verdiano e meno di un anno prima di vestire per primo i panni di Falstaff. La tradizione che vuole i due lavori abbinati – peraltro non sempre rispettata, specie in tempi recenti - risale al 19 dicembre 1926, quando lo stesso Mascagni li diresse insieme alla Scala, segnando così anche la prima rappresentazione di Pagliacci su quel palcoscenico. Sul piano musicale, però, le due opere presentano notevoli differenze: a dispetto del soggetto, uno dei più significativi del verismo letterario, l’ottica compositiva di Cavalleria rusticana è sostanzialmente rivolta alla tradizione del melodramma italiano, mentre Leoncavallo, giustapponendo linguaggi eterogenei, crea un’opera stilisticamente più discontinua, ma decisamente proiettata in avanti, verso i prodromi dell’espressionismo.
L’allestimento scaligero è stato curato da Mario Martone, con le scene di Sergio Tramonti, i costumi di Ursula Patzak e le luci di Pasquale Mari. Per Pagliacci Tramonti ha “[…] ripensato a un’acquaforte di van Gogh: una campagna brulla con alberi secchi. E’ lì in mezzo il teatrino dei girovaghi. La linea registica è stata determinante nella scelta di un paesaggio del giorno d’oggi: un accampamento di giostrai e acrobati ai margini di una rampa autostradale. Una periferia qualsiasi di un qualsiasi centro urbano.” L’idea registica, sostanzialmente, regge, ma c’è un eccesso di moltiplicazione dei punti di vista scenici, che non tiene conto del fatto che la visibilità non è la stessa per tutti gli spettatori: in particolare, non è ottimale che Silvio assista allo spettacolo dei teatranti seduto nella prima fila della platea: la sua angoscia durante la recita, il suo inseguimento da parte di Canio e il suo assassinio avvengono così in un punto che buona parte del pubblico non può vedere agevolmente. Cavalleria rusticana è stata invece completamente privata della dimensione solare insita nella musica a creare contrasto con la crudezza della vicenda. La prima parte ha come punto di riferimento l’interno della chiesa in cui si svolge la celebrazione pasquale, e di fronte a tutto il paese ivi riunito si susseguono gli incontri e gli scontri fra i personaggi del dramma. La seconda parte ha luogo invece in un esterno caratterizzato dal tronco di un albero secolare, le cui fronde sono costituite dalla loro ombra proiettata sul pavimento: una suggestiva allusione alle radici di costumi dal sapore arcaico, già precedentemente evocate dall’uccisione dell’agnello all’inizio della cerimonia di Pasqua. Il finale addio di Turiddu alla madre avviene invece in una scena vuota e circondata dal buio, dentro il quale il giovane viene inghiottito correndo verso il fatale duello con Alfio, e in cui si perderà anche Santuzza, la cui figura Martone assimila a un’eroina da tragedia greca, che con il proprio agire innesca un meccanismo fatale. Una lettura dunque non priva d’interesse, alla quale non si vede perché il regista abbia voluto aggiungere, nel corso del preludio eseguito a scena aperta, il passaggio di una piattaforma mobile su cui era situato un bordello in piena attività.
Il celeberrimo Prologo di Pagliacci era affidato ad Ambrogio Maestri, il quale però non appariva a proprio agio nelle vesti di Tonio, di cui riusciva a sottolineare la componente cinica, ma non quella brutale che è essenziale in questo personaggio. Discreta la prova vocale di Kristine Opolais (Nedda), ben poco chiara, però, nell’articolazione del testo; molto bene Celso Abelo (Peppe/Arlecchino), corretto Mario Cassi (Silvio). Ai suoi esordi, quasi vent’anni or sono, José Cura – che qui interpretava Canio – aveva tutte le carte in regola per poter diventare uno dei più grandi tenori contemporanei, ma il modo discutibile con cui egli ha gestito le proprie risorse vocali glielo ha impedito. Ottime doti ha dimostrato di possedere, nelle vesti di Turiddu, Yonghoon Lee, sudcoreano in carriera da circa tre anni - subentrato a Salvatore Licitra dopo le prime due recite - che associa a una voce potente e ben educata una bella presenza scenica e grande sensibilità interpretativa. Bravo Ivan Inverardi come Alfio, ruolo nel quale si è alternato con Claudio Sgura; brava anche Giuseppina Piunti nella parte di Lola. Luciana D’Intino ha prestato la sua stupenda voce e la sua grande perizia tecnica al personaggio di Santuzza, ma il suo canto era più verdiano che verista. Elena Zilio è stata veramente grande nel tratteggiare mamma Lucia, figura troppo spesso trattata con superficialità in quanto a torto considerata minore, quando invece è una grande ruolo tragico degno dell’arte di Sofocle: colpisce in particolare il suo modo di scolpire la parola, che ne esalta anche la presenza scenica. Un plauso particolare all’orchestra e al coro, che Daniel Harding ha diretto con sufficiente passione, ma anche con qualche problema di intesa ritmica con il palcoscenico. Il rimprovero, che qualche critico gli ha mosso, di avere ecceduto nel volume orchestrale creando problemi ai cantanti deve indurci a riflettere sulle particolarità che dovrebbero caratterizzare le voci che si impegnano nel repertorio verista e che, mentre fino a cinquant’anni fa tendevano a invadere anche altri repertori, oggi decisamente scarseggiano, o non sono correttamente messe a frutto.
Vittoria Lìcari